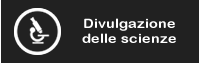[ FISICA ] LA SCIENZA CHE COMBATTE GLI INCENDI
Gli incendi
boschivi sono una piaga mondiale, un fenomeno che ogni anno sconvolge e
distrugge l’ecosistema e l’economia, creando sfollati e vittime tra le
popolazioni locali. Per quanto riguarda il nostro Paese, tutte le regioni ne
sono interessate, anche se con gravità differente e in periodi diversi
dell’anno. Le condizioni ambientali e climatiche della penisola italiana
favoriscono lo sviluppo di focolai principalmente in due stagioni dell’anno:
nelle regioni peninsulari centro - meridionali, dove il clima è mediterraneo,
il fuoco si sviluppa prevalentemente nella stagione estiva, calda e siccitosa;
nelle regioni settentrionali dell’arco alpino, ma anche nelle zone appenniniche
in alta quota, il periodo critico è la stagione invernale - primaverile, quando
la vegetazione è stata seccata dal gelo.
Una dei principali problemi per chi si
appresta ad affrontare e combattere un incendio è la difficoltà a vedere oltre
la fitta coltre di fumo e fiamme. A bypassare questo problema ci pensa ora la
scienza, grazie a un nuovo dispositivo olografico a infrarossi in grado di
visualizzare scene interamente nascoste da fumo e fiamme. A motivo di orgoglio,
si tratta di un’invenzione tutta italiana, sviluppata dal team di imaging e
olografia digitale dell’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale
delle Ricerche di Firenze (CNR-INO).
Già nel 2013, lo stesso team aveva realizzato
un analogo dispositivo, ma molto più pesante e di grandi dimensioni, che era
stato utilizzato soltanto in test di laboratorio. Ora, i ricercatori sono
riusciti a miniaturizzare il sistema, a renderlo portatile e applicabile in
ambito operativo.
I comuni sistemi di imaging – video e
fotocamere nel visibile – non sono in grado di “vedere” oltre la coltre di
fuoco e fiamme. D’altra parte, le telecamere nell’infrarosso consentono sì di
vedere oltre il fumo, ma non oltre le fiamme. Il nuovo dispositivo è invece in
grado di bypassare entrambi gli elementi e le sue dimensioni ridotte lo rendono
perfettamente adatto all’utilizzo durante le operazioni di soccorso, per
esplorare in sicurezza e rilevare la presenza di persone, animali e oggetti di
interesse.
Questa scoperta è un esempio lampante di come la
ricerca, nata in laboratorio, possa trovare soluzioni a problemi concreti. Attualmente
allo stato di prototipo, ci si augura che il nuovo visore passi presto alla
fase di produzione aziendale su scala globale.[ ASTRONOMIA ] UN BAGLIORE VERDE NELLA NOTTE MARZIANA
Quando i futuri
astronauti esploreranno le regioni polari di Marte, vedranno un bagliore verde
illuminare il cielo notturno. È quanto osservato, per la prima volta, dalla
missione ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea.
Il bagliore notturno è
un fenomeno che si osserva anche sulla Terra e non ha nulla a che vedere con la
luminosità diffusa dovuta all’illuminazione artificiale. Si tratta di un
fenomeno naturale, che si verifica nell’atmosfera planetaria quando due atomi
di ossigeno (O) si combinano per formare una molecola di ossigeno (O2).
Nel caso di Marte, il
fenomeno era stato previsto teoricamente, ma mai osservato fino a oggi. Gli
atomi di ossigeno compiono un lungo viaggio: si formano sul lato diurno del
pianeta rosso, quando la luce solare fornisce alle molecole di anidride
carbonica (CO2) energia sufficiente a farle scomporre nei suoi
elementi basilari, ossigeno (O) e carbonio (C). Quando gli atomi di ossigeno migrano
verso il lato notturno e smettono di essere eccitati dal Sole, si raggruppano e
formano le molecole O2: questo processo di raggruppamento è
accompagnato da emissione luminosa nella frequenza del verde.
Secondo il recente
studio – condotto da un team del Laboratorio di Fisica Atmosferica e Planetaria
dell'Università di Liegi – questo bagliore potrebbe essere sufficientemente intenso
da consentire ai futuri esploratori marziani di vedere e ai rover di navigare
nelle notti buie.